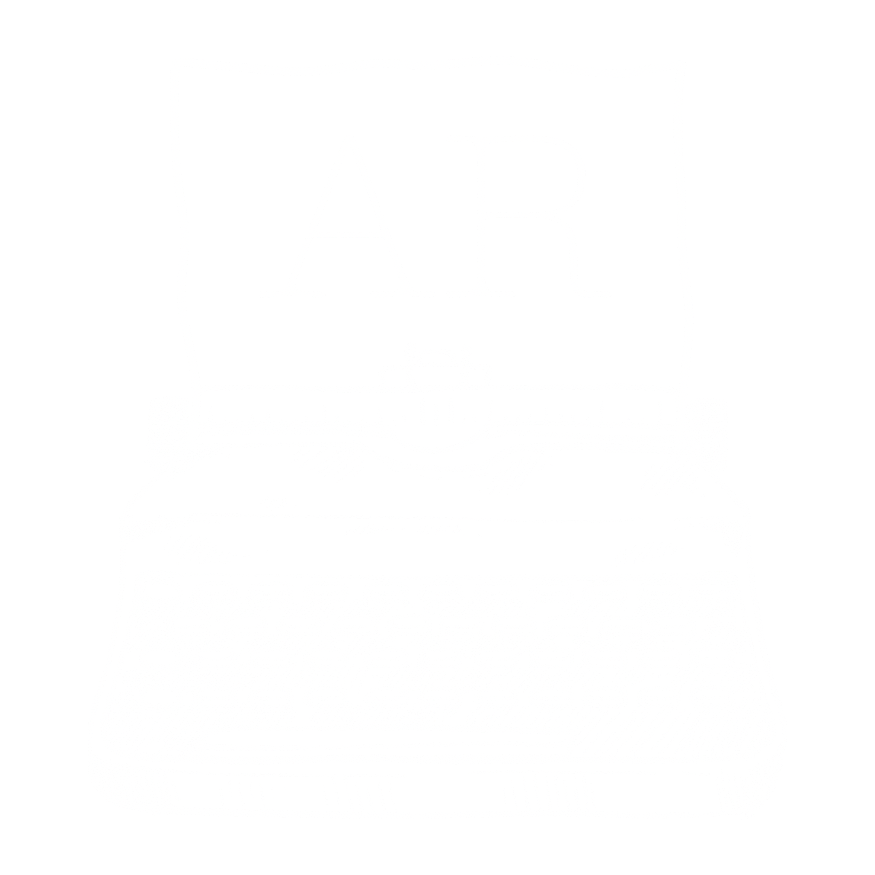Buongiorno, è venerdì 14 ottobre, il caffè è amaro, com’ adda’ essere, e state leggendo ‘Na tazzulella ‘e café: le note del mio iPhone.
Ci sono diverse cose di cui vorrei parlare, di La Russa che diviene Presidente del Senato, delle parole di Liliana Segre e del significato profondo degli stivali sporchi di fango di Aboubakar Soumahoro. Parlerò di queste cose molto presto ma non oggi.
Sento prima il bisogno di concludere questa prima fase del blog, nella quale ho davvero assecondato il mio umore e condiviso ciò che mi andava in quel momento di condividere. Da lunedì sarò molto più focused su attualità e politica, promesso.
Nel mentre, vi racconto una storia…
Ignoto
“Ho paura dell’ignoto, di ciò che accadrà e di non stare bene” pensò Martino accendendosi una Gitane Brune sans Filtres, appena presa dal pacchetto semivuoto.
A Roma era complicato recuperare le Gitanes Brunes sans Filtres. Non che a Parigi fosse molto più semplice. Trovarne anche solo una decina era fastidiosamente complesso ovunque.
Ma Cécile, sua cugina, qualcheduno a cui chiedere o scroccare qualcosa lo trovava sempre.
Solitamente erano uomini ammaliati dalla sua bellezza. Incapaci di dire no alle sue richieste.
Lui per primo.
Ripensò al suo cappello nero di feltro, terminato nelle mani della cugina il Natale scorso, o alla sua collezione di vinili, mutilata ogni santa Pasqua di un titolo importante.
Riportare alla mente ciò produsse un effetto domino inaspettato nel suo flusso di coscienza.
Ecco che, le Gitanes Brunes sans Filtres e le cose che la cugina gli aveva portato via passarono presto in secondo piano.
L’imbarazzo lo colse impreparato e gli colorò prepotentemente le guance quando i suoi pensieri tornarono all’estate scorsa: non aveva saputo opporsi alla tentazione di guardare oltre la porta semiaperta Cécile toccarsi sotto la doccia.
Quell’immagine, di dieci secondi appena, arrivava sempre senza alcun avvertimento. Senza bussare alla porta.
Ringraziò un qualche dio del tabacco per il bite tenace delle Gitanes Brunes. La miscela francese Caporal allontanò il ricordo di Cécile in doccia – ne fu sollevato e al contempo dispiaciuto – e scese su di lui come una bonaccia.
Martino era tornato ad abitare a Roma da poco. Se n’era andato a Parigi coi suoi dopo le scuole elementari ed era stato abbastanza lontano da Roma da scordare il nome di quei quattro compagni di classe che andavano a casa sua a giocare a 10 anni.
Era tornato ad abitare a Roma per studiare violino al conservatorio in via dei Greci che, neanche a farlo apposta, era di Santa Cecilia.
Il violino era al centro dei suoi pensieri ogni giorno, anche adesso. Anche in quel momento, prima che ebbe il tempo di accorgersene, prese possesso dei suoi pensieri.
Studiava da un paio d’anni a casa del vecchio Giacomo Sora, compositore noto ai più a Roma, ormai quasi del tutto sordo, maestro d’orchestra in pensione con il capriccio delle carte. Tressette, briscola chiamata e scopa a fidasse.
Giacomo Sora gli aveva insegnato a dare corpo alla musica. Era sorprendente come seguisse la musica, percependone le più nascoste sonorità e i contorni, nonostante la incipiente sordità che ne impediva un ascolto felice.
Martino aveva imparato non solo a suonare il violino dal maestro Sora, ma anche a giocare a scacchi e ad amare la torta di mele cotogne di Edna, la moglie del maestro.
Martino era per quell’uomo il figlio maschio che lui e Edna non avevano mai avuto. Trascorreva ore e ore, dopo la scuola, a casa loro. Suonava il violino, si rimpinzava per bene e faceva il filo a Elisa, la nipote del compositore. Elisa aveva un anno meno di lui, era una delle studentesse migliori di uno dei licei classici più importanti di Roma ed era di “squisita fattura” – come le ripeteva sempre Martino, punzecchiandola.
Elisa non era una 18enne come le altre. Era una donna e non di quelle che si vedono in giro oggi. Era una donna d’altri tempi.
Mentre lui, come ogni suo coetaneo, era perennemente alla ricerca del proprio posto, impegnato nel raccogliere i fogli, che il vento metteva puntualmente in disordine, di uno spartito, complesso da eseguire; Elisa interpretava il suo ruolo di figlia e studentessa senza alcun cedimento. Non andava a ballare, non dava corda a chiunque e non postava foto di sé mezza nuda sui social. Era come ancorata, felicemente ancorata, a un mondo passato. A una storia in cui la cucina è vita. In cui ci sveglia con l’aroma del caffè e la sera ci si riunisce attorno alla tavola e ci si racconta la giornata.
Una cucina in cui ci sono appese al muro le padelle di ferro della nonna. Di misure diverse e non particolarmente vecchie ma annerite dal fuoco. Padelle di poca profondità e ampia superficie. E con due piccoli manici.
In quella cucina Martino si era innamorato di Elisa – forse avrebbe dovuto dirglielo – e delle sue mani. La guardava togliersi gli anelli e cominciare a impastare la frolla per la crostata. E quando lei preparava qualcosa ai fornelli l’abbracciava da dietro e le baciava il collo. Il profumo di glicine e lei che brontolava il solletico, poi però rideva e schiudeva le labbra in un sorriso, che Martino intravedeva solo ma conosceva bene.
Grazie a Elisa cominciò ad accogliere, a contenere nella sua indole, di per sé molto poco nordica, la molteplicità e la pluralità di quella terra mediterranea di contraddizioni.
E grazie a Giacomo Sora era entrato in contatto con Elisa. Lei solerte ed elegante; lui no, pigro, ma costante – nella pigrizia.
Tra i due si creò presto un legame con le radici nella condivisione. Dello studio.
Era straordinario come un violino fosse stato capace di produrre una musica tanto rivoluzionaria nella vita di Martino.
Concluse la sua sigaretta con calma, a piccoli tiri. Una volta spenta, si guardò attorno. Era solo. Alle sue spalle l’ingresso della scuola. Di fronte a sé il cortile della Sapienza quasi vuoto. Pensò alla velocità con cui gli studenti si erano dileguati. In quattro e quattr’otto, il tempo di una sigaretta.
Buon weekend.
Ce verimm riman, stàteve buòno!